|
GIACOMO
ANNIBALDIS |
| |
|
Su
Federico il sole della
leggenda non tramonta mai
|
| |
|
Parla
il medievista pugliese
Cosimo Damiano Fonseca, uno
dei curatori della «Enciclopedia
Fridericiana» della
Treccani, edizione raffinata
e punto fermo sul «puer
Apuliae».
|
| |
|
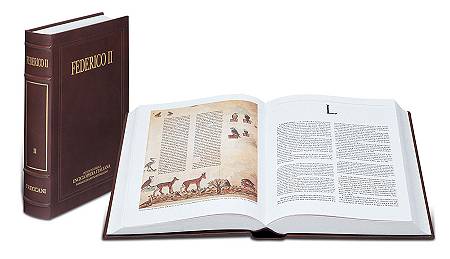
Su
Federico II di Svevia sembra che il sole della
leggenda non tramonti mai. E anche dopo le
rievocazioni del centenario della nascita, dieci
anni fa (a Bari si svolsero convegni e una
mostra significativa), l'interesse per il «puer
Apuliae» non si attenua. Anzi si rinfocola. Uno
«stupor mundi»: è il caso di dirlo,
sfogliando i due raffinati volumi su Federico II,
Enciclopedia fridericiana, editi dalla
Treccani. Il prezzo non è per tutte le tasche
(900 euro), ma i curatori (nonché i
collaboratori) sono una garanzia: con Girolamo
Arnaldi, Ortensio Zecchino, Arnold Esch, Antonio
Menniti Ippolito e Alberto Varvaro c'è anche il
nostro Cosimo Damiano Fonseca, cui abbiamo
rivolto alcune domande.
Professore, un Federico
II da collezione? Copie numerate, prezzo da
regalo di lusso, targhetta d'argento per il
possessore? Ma dopo la prima edizione è almeno
prevista una diffusione più accessibile di
tanto sapere?
«Dalla più celebre
Encyclopédie
di d'Alembert e Diderot alle varie Enciclopedie
nazionali, come la Britannica e la stessa grande
Enciclopedia Treccani, senza ricorrere neppure
alla civetteria delle copie numerate e
conseguentemente alla rarità bibliografica, il
prezzo non è stato mai "modico". I costi
dell'operazione sono molto alti tenuto conto
delle spese di primo impianto, del numero delle
pagine (oltre 1800) e delle voci (oltre 600),
della qualità dei collaboratori (circa 220),
della consistenza dell'apparato delle immagini,
della rilegatura e via elencando. Enciclopedie
di questo tipo - e solo per riferirci ai
prodotti dell'Istituto Treccani: la Dantesca, la
Virgiliana, l'Oraziana, ecc. - sono destinate a
durare nel tempo e, quindi, l'acquisizione
diventa un vero e proprio investimento. La Fridericiana, pur essendo la prima
edizione numerata, sta riscontrando un enorme
successo sia in Italia che all'estero: segno
evidente dell'interesse che Federico II continua
a riscuotere in tutto il mondo».
Due volumi
sono sufficienti per dire tutto su Federico?
«Non
è improbabile che ai due volumi ora editi se ne
possa prevedere l'aggiunta di un terzo relativo
alle opere dello stesso imperatore che, come è
noto, fu legislatore con il libro sulle
Costituzioni di Melfi, poeta con i componimenti
della Scuola Siciliana, etologo ante litteram
con il famoso trattato sulla falconeria».
Quali
sono i punti forti che lo rendono «uomo di
successo» anche nei nostri tempi?
«C'è una
voce, in questa Enciclopedia fridericiana
dedicata al "mito" di Federico II: mito storico
che lo stesso svevo ha accreditato ricorrendo ad
arditi accostamenti biblico-messianici e
accentuando il carattere sacrale della dignità
imperiale, ma che la tradizione ha avvalorato
sino ad inventarsi una sorta di reclusione
sulfurea nell'Etna in attesa di una risurrezione
e ascensione al cielo, come quella di Elia e di
Alessandro Magno. E non parliamo delle leggende
fiorite intorno al personaggio collegate al
linguaggio criptico delle profezie sibilline,
alle tesi del gioachinismo che riconoscevano
all'imperatore una duplice funzione, quella di
alleato nella riforma della Chiesa e l'altra di
Anticristo incarnato».
Questo nei secoli
scorsi. Ma oggi?
«Non si dimentichi il giudizio
di Nietzsche che in Federico II aveva indicato
l'eroe antimoderno e anticristiano influenzando
l'autore della più celebre biografia dello
svevo, Ernst Kantorowicz. Quello che è certo è
che ogni epoca si è creato il suo Federico,
secondo il tipo di interessi culturali,
religiosi e politici che perseguiva. Basti
leggere le ultime tre biografie, quelle scritte
dall'inglese Abulafia, dal tedesco Sturner e dal
francese Racine, per avere una riprova. Oggi di
Federico si apprezza l'intuito politico, la
ricerca della razionalità nel diritto, il
concetto di laicità, la fede nella scienza,
insomma una serie dei valori che interpretano le
pulsioni della nostra società».
L'Enciclopedia
apporta molte novità. Ma dirime l'antica
diatriba su Federico: fu l'ultimo grande del Medioevo o il magnifico anticipatore
dell'Umanesimo (e della modernità)?
«È questa
consapevolezza di un personaggio di transizione
a cavallo tra medioevo ed età moderna che ha
finito con ingenerare perplessità circa
l'interpretazione data da David Abulafia con il
suo profilo biografico di Federico II. Lo
storico di Cambridge lo ha considerato, come
recita il titolo, un imperatore medioevale. In
realtà a Federico va riconosciuta una poderosa
capacità di anticipatore di nuove realtà, di
precorritore della modernità senza ovviamente
decontestualizzarlo dalla sua epoca e, quindi,
forzare il giudizio storico con categorie che
appartengono ad altre sensibilità e a più
mature e diverse esigenze».
Quanto di Puglia e
Lucania emerge in questa mappa enciclopedica?
«Puglia
e Basilicata sono corposamente presenti in
questa enciclopedia non solo nelle voci
generali, ma anche in quelle specifiche: a
cominciare dalle voci dedicate complessivamente
alle due regioni all'interno delle quali aveva
creato i centri della sua attività di governo,
come a Foggia, la terza capitale del Regno, con
il suo Palazzo; come a Melfi dove sviluppò una
intensa attività culturale di cui rimangono
cospicue testimonianze i colloqui astrologici
con Michele Scoto, le traduzioni delle opere di
Avicenna e di Aristotele, la composizione delle Constitutiones, la redazione del
De arte venandi.
Ci sono voci poi dedicate ai porti, alle città
nuove, ai castelli, primo fra tutti Castel del
Monte - interpretato con categorie meno, anzi
affatto, indulgenti all'esoterismo -, alle
masserie, ai luoghi di piacere, ai protomagistri,
ai giuristi, ai gruppi etnici, ecc.: insomma una
ventina di lemmi delineano la facies sveva della
Grande regione Puglia-Basilicata».
Federico e
le sue donne? Concediamoci un po' di mondanità.
Nelle nostre terre di Puglia e Basilicata, oltre
alle tombe delle regine in Andria e alla
leggenda di Bianca Lancia a Gioia, quali altre
tracce sono rimaste delle donne di Federico?
«Ah,
Federico e le donne! Argomento sempre fascinoso
tenuto conto che quella mala lingua del cronista
parmense, fra' Salimbene de Adam, sulla lussuria
dell'imperatore non aveva usato eufemismi o
reticenze. E non era stato certo l'unico il buon
francescano. Forse, però, si dimenticano i
costumi del tempo e quella parte di "sultanato"
che portava Federico a vivere secondo le
abitudini orientali con grande disinvoltura».
Perciò si continuerà ad alimentare una
immagine torbida dei suoi amori?
«Una cosa è
certa: le fonti su questo tema scarseggiano,
salvo il caso di Bianca Lancia, madre di
Manfredi, - cui è dedicata una voce -. Il
cronista Tommaso Tosco, che scriveva nel 1279,
insinua l'ipotesi che Federico II avesse avuto
rapporti promiscui tanto con la madre quanto con
le figlie. E poi sia nell'affresco scoperto a
Bassano sia in quello, peraltro contestato, di
Melfi, il quadretto della famiglia di Federico,
tutta compostezza iconografica e amore cortese,
fa aggio sulle avventure erotico-sentimentali
entro le quali aveva perfettamente incarnate la
focosa rudezza dei costumi teutonici con il
delicato esercizio dei piaceri connesso ai
profumi isolano-mediterranei».
Giacomo
Annibaldis
|
|
